di Simone Mariotti –
I gamberi stavano scoppiettando sulla graticola.
Eravamo abbastanza lontani dal fiume, quasi alla prima periferia della città, e attorno a noi i segni della grande alluvione di agosto non erano così profondi. Il Mekong ci aveva dato dentro pesante, ma dopo tutto Vientiane è sempre un po’ come un calzino rivoltato, di quelli di lana grossa, con tutti quei fronzoli che ciondolano con caloroso disordine. Erano solo più bagnati del solito.
Il chioschetto era all’angolo di una strada lungo un piccolo canale. Poco traffico, qualche moto. La casa di Phan era nello stesso stabile, una struttura a un piano, con qualche camera sparsa. Lui ne possedeva una, con un bagno in comune, ma non dormiva lì, non sempre. Per tirare su qualcosa, affittava la s ua stanza ai lavoratori che passavano in città, gente comunque povera che aveva bisogno di un posto da poco per dormire. Lui intanto si appisolava al dormitorio, quando non lavorava, dalle 14 alle 23, orario continuato, nell’albergo dove lo incontrai al mio arrivo in Laos. Poi la sera una zuppa e una Beerlao, o anche due.
ua stanza ai lavoratori che passavano in città, gente comunque povera che aveva bisogno di un posto da poco per dormire. Lui intanto si appisolava al dormitorio, quando non lavorava, dalle 14 alle 23, orario continuato, nell’albergo dove lo incontrai al mio arrivo in Laos. Poi la sera una zuppa e una Beerlao, o anche due.
La mattina studiava, quando poteva, chissà come e dove, e con che mezzi. E scoprire da dove gli venisse l’istinto di farlo, in quel casino di vita che si ritrovava, era un premio per chi entrava in quella piccola Asia ancora lenta, che sapeva quasi di Sudamerica, così  lontana dalla nuova frenesia orientale, ancora ingarbugliata e soffocata da un regime stanco e vecchio, ma che non vuole mollare la presa.
lontana dalla nuova frenesia orientale, ancora ingarbugliata e soffocata da un regime stanco e vecchio, ma che non vuole mollare la presa.
Ma quell’istinto Phan lo aveva. Autodidatta su tutto, annaspava lento, e a 33 anni sognava di avere una famiglia, di lavorare per conto suo, magari di aprire una guesthouse a casa del fratello, che stava in campagna nel sud del paese. Ma in quella parte di Laos non ci va nessuno.
«Portaceli tu!»
«Con cosa, con la tua libertà?»
I gamberi erano pronti.
«Non ti interessa proprio?»
«Non sapete nulla, voi», scherzò serio, «nulla. Lui studia il linguaggio php», mi indicò il nostro cuoco neanche ventenne, «e guarda che tra un po’ ti interroga. Mi farà un sito come il tuo… sembra strano vero? In fondo posso fare quasi tutto quello che voglio».
«Allora dimmi quello che pensi».
«Sono solo stanco, e tu? Ci manca ancora un po’ per le “tue” cose, non tanto. E anche un po’ di voglia nostra, in effetti. Quei ragazzi imprigionati di cui mi dici… non so; nessuno lo sa credo, o quasi. Ma dopotutto rispetto a dieci anni fa qui è tutto un altro mondo, anche rispetto a due. Ma voi non sapete nulla… Tu mi parli male dei vietnamiti, ma qui li consideriamo dei veri fratelli…»
per le “tue” cose, non tanto. E anche un po’ di voglia nostra, in effetti. Quei ragazzi imprigionati di cui mi dici… non so; nessuno lo sa credo, o quasi. Ma dopotutto rispetto a dieci anni fa qui è tutto un altro mondo, anche rispetto a due. Ma voi non sapete nulla… Tu mi parli male dei vietnamiti, ma qui li consideriamo dei veri fratelli…»
«Fratelli maggiori, per il tuo governo… ho capito lascio perdere».
«Dai che devo tornare», mi disse sorridendo.
Risalimmo sulla sua moto. Lui era tramortito dalla stanchezza. Era dall’alba che girava con me, e in tre quarti d’ora avrebbe iniziato a lavorare. I suoi colleghi dell’albergo sembravano intontiti, lui invece, il giorno del mio arrivo, appena scoperto che scrivevo, che in Italia stava per uscire un mio libro di narrativa di viaggio disse d’istinto: “Ah! Molto interessante! Allora ti porto in giro la mattina così scriverai anche di me”. E’ quell’istinto che non ti dà pace, ma che ti fa riposare bene anche in un dormitorio, se riesci a non sentirti escluso da quello che conta per te.  Lo lasciai al distributore dietro l’angolo, vicino all’albergo. I suoi capi non dovevano sapere che stava studiando il modo di diventare una guida, che cercava un po’ di pubblicità e che in cambio gli bastava un po’ di benzina per la moto, qualche birra e un po’ di gamberi in più. Avrebbero voluto una percentuale anche su quelli. Ci saremmo visti per cena al piccolo mercato alimentare notturno, il più piacevole in cui abbia mai mangiato.
Lo lasciai al distributore dietro l’angolo, vicino all’albergo. I suoi capi non dovevano sapere che stava studiando il modo di diventare una guida, che cercava un po’ di pubblicità e che in cambio gli bastava un po’ di benzina per la moto, qualche birra e un po’ di gamberi in più. Avrebbero voluto una percentuale anche su quelli. Ci saremmo visti per cena al piccolo mercato alimentare notturno, il più piacevole in cui abbia mai mangiato.
Il Mekong era tornato calmo. I chioschi alimentari lungo l’argine brulicavano di campagna come poteva accadere solo nel più grande villaggio d’Asia, con le sue semplici strade sterrate a pochi passi dal centro. Vientiane era così bella, quasi fresca. Non avevo voglia di muovermi.
I gamberi sono ancora lì, in quell’Asia sudamericana,  che non chiede cibo. E Phan alla fin fine, vuole quello che voglio io, che vogliono tutti, forse: un po’ meno casino, che ancora ne abbiamo troppo in tanti, con una dose sempre più scarsa di serenità e un istinto che per fortuna ancora ti morde.
che non chiede cibo. E Phan alla fin fine, vuole quello che voglio io, che vogliono tutti, forse: un po’ meno casino, che ancora ne abbiamo troppo in tanti, con una dose sempre più scarsa di serenità e un istinto che per fortuna ancora ti morde.
Potete trovare altri racconti di Simone nel suo sito: www.simonemariotti.com
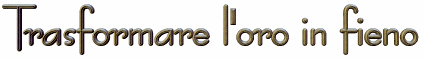
Droga, guerra e occidente: trasformare l’oro in fieno
Pubblicato il 30 settembre 2009 su La Voce di Romagna in prima pagina
Muang Sing, Laos, settembre 2008.
Non mi ricordo il suo nome né quello della sua amica. Il suo mi pare fosse qualcosa come Slatah, chiamiamola così. Era una donnetta della tribù degli akha, sulla cinquantina credo, ma ne poteva avere anche dieci di meno. Viso simpaticissimo, caciarona, tutta collanine, braccialetti e pezze varie, un misto di mercanzia colorata che teneva un po’ nella sua borsa e un po’ in un cesto che la sua amica portava come uno zaino, ma che invece degli spallacci aveva una sola fascia che si faceva passare attorno alla testa, reclinata, mentre il cesto poggiava sulla schiena.
Muang Sing è uno degli ultimi avamposti del Laos settentrionale a una manciata di chilometri dalla Cina. Poche strade, quasi tutte sterrate, pochissima gente. Una valle silenziosa, bellissima, con tanti campi coltivati, circondata dalle foreste e dalle colline, luogo di incontro per le tante tribù delle zona. L’unico posto con un po’ di animazione era il mercato. Era un vasto spiazzo che conteneva al centro una semplice struttura al cui interno i contadini vendevano i propri prodotti, mentre attorno arrivavano i camioncini diretti nelle varie parti della provincia e i tuk-tuk.  Anche io ero arrivato lì da Luang Nam Tha con uno di quelli, dopo quasi due ore di estenuanti sballottamenti, in compagnia di una coppia di promessi sposi brasiliani e di un loro amico arrivato da Londra, ma anche lui di San Paolo, che li aveva incrociati nel loro lungo “viaggio pre nuziale” per una settimana.
Anche io ero arrivato lì da Luang Nam Tha con uno di quelli, dopo quasi due ore di estenuanti sballottamenti, in compagnia di una coppia di promessi sposi brasiliani e di un loro amico arrivato da Londra, ma anche lui di San Paolo, che li aveva incrociati nel loro lungo “viaggio pre nuziale” per una settimana.
Dal mercato, Slatah ci aveva portati al suo villaggio. Mentre lei ci cucinava del riso rosso con erbe e uova, il marito aveva accuratamente preparato la parte della capanna/palafitta adibita all’oppio. A turno ci siamo distesi, girati su un lato con le gambe leggermente piegate, con lui che dava fuoco alla pipa mentre il fumatore tirava. Niente di forte, poco meno che bere un paio di grappini in più oltre il consentito.
Fumare oppio in un villaggio ahka non è che sia l’esperienza più trascendentale che ti può capitare. Nel nord della Thailandia è facile trovare anche le cartoline con un fumatore d’oppio, tanto è culturalmente diffusa la vietatissima pratica. E’ curioso, ma la cosa più impressionante sono i bambini, specialmente le bambine, che girano per i villaggi con le loro saccocce piene di marijuana che ti offrono a pugnate come se fosse rucola.
Tutto è ufficialmente proibito, ovviamente. Il marito di Slatah non voleva che gli facessimo delle foto sul “luogo del delitto”, ma non è che fosse esattamente terrorizzato. Lui diceva di non essere un coltivatore di papaveri, che quella che fumava era roba di amici, che non commerciava, e in effetti per la nostra piccola fumata ci chiese solo un dollaro a pipa, lo stesso prezzo del pasto che avevamo fatto al mercato. Ci disse che i campi veri erano oltre le colline, ma che quello che coltivavano là non restava mai in loco, se non quello necessario a tenere su i contadini. La marijuana invece abbonda sempre, ma con quella si fanno pochi “affari internazionali”.
Della marijuana che comprammo da Slatah e dalla sua amica al mercato, ce ne fumammo una piccola parte la sera al tramonto sul patio della nostra guesthouse, soli in mezzo alla campagna, il cui silenzio era rotto con discrezione solo da un minuscolo speaker attaccato al nostro lettore mp3 e da un buon numero di cicale. Il resto rimase lì, inutilizzata, pochi euro per arrotondare il bilancio degli akha, e il rimpianto per i miei amici, che la apprezzavano molto più di me, che invece ne adoro più che altro la fragranza.
nostro lettore mp3 e da un buon numero di cicale. Il resto rimase lì, inutilizzata, pochi euro per arrotondare il bilancio degli akha, e il rimpianto per i miei amici, che la apprezzavano molto più di me, che invece ne adoro più che altro la fragranza.
E’ la solita ipocrisia. Ricordavo un articolo di qualche anno prima, sul domenicale del Sole, che sono poi andato a rileggere. Era il 2002 e Massimo Dini raccontava di una sua esperienza simile a Luang Prabang, la vecchia capitale imperiale, per fermarsi poi su un particolare della realtà del Laos: “Il governo di Vientiane, la capitale dove ancora sventola la bandiera rossa con falce e martello, è impegnata a bruciare i campi di papavero da oppio. In cambio, l’Onu costruisce infrastrutture e promuove colture alternative per le tante tribù che sopravvivono in condizioni primitive al di là di boschi profondi e selvaggi. Questa è la versione ufficiale. La verità però è un’altra. I campi esistono ancora, appartati, lontani dai villaggi. Se, al tramonto, quando gli uomini rientrano dai campi, ci si addentra in una qualunque capanna di bambù a palafitta, si avverte subito l’odore acre della droga”. Poi, ricordando la placida e serena calma delle notti laotiane, finì con una considerazione: stando là “a nessuno viene in mente che questo paese è il terzo produttore mondiale di oppio dopo Birmania e Afghanistan. E che l’occidente, lungi dall’essere vittima, è stato, e resta, il maggior complice dei contrabbandieri di morte della Repubblica popolare democratica del Laos”.
Io ero da quelle parti un anno fa, e la situazione non era cambiata. Non è migliorata né in Afghanistan, dove la coltivazione è esplosa, né in Birmania, preziosa fonte di dollari per il sanguinario e inetto regime al potere.
Il fallimento delle politiche di sradicamento e di conversione è inevitabile essendo i paesi produttori governati da regimi che hanno solo l’interesse a raccontare balle per avere contributi e fare il contrario, e fino a che il ricco occidente continua a pagare bene grazie al proibizionismo le cose non cambieranno.
E’ l’utopia di voler distruggere una cultura della droga che in quelle popolazione dura da secoli, per non dire millenni, e che l’occidente ha convertito in cultura di morte tramutando la foglia di coca in cocaina e l’oppio in eroina.
Oggi qualcosa sembra cambiare. Da quest’estate la comunità internazionale pare intenta a perseguire una nuova strategia in Afghanistan, tesa a non sradicare più le coltivazioni per non far arrabbiare i contadini e peggiorare le cose. Chissà se capiranno anche che per far sì che le droghe tornino a ricoprire solo il loro ruolo storico, culturale e farmacologico nella vita di quei popoli, e anche dei nostri, bisogna trasformarle da oro in fieno, legalizzandole?
Potete trovare altri racconti di Simone nel suo sito: www.simonemariotti.com
| Il Viaggio Fai da Te – Hotel consigliati nel mondo |




